Una recensione di “Anni luce”
Andrea Pomella, add editore
Nel 2007 Eddie Vedder – cantante e frontman dei Pearl Jam – pubblica un album meraviglioso. È la colonna sonora di Into the Wild, il film diretto da Sean Penn e uscito nelle sale lo stesso anno. In quel disco la voce di Edd ti risuona nello stomaco mentre graffia e accarezza, si appoggia a sonorità acustiche, percussioni e ukulele che difficilmente si possono apprezzare nei lavori dei Pearl Jam.
Ma il 2007 è qui vicino, quasi dietro l’angolo. Lontani, invece – quasi lontanissimi -, sono i primi anni ’90. Gli anni nei quali i Pearl Jam hanno dato vita a una “santa trinità” composta da Ten, il loro primo esplosivo disco del 1991, Vs. e Vitalogy, rispettivamente usciti nel 1993 e 1994.
“Anni luce”, l’ultimo romanzo di Andrea Pomella (add editore) è l’espulsione quasi psicoanalitica che l’autore compie di quegli anni, della vita trascorsa mentre i brani di quei tre dischi risuonavano attraverso le musicassette e i walkman.
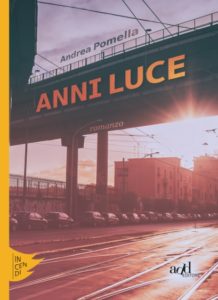 I primi anni ’90 sono una parentesi devastante. La coda delle ideologie – il loro ultimo sussulto – si è diffusamente trasformata in tentativi (estremi) di tenerle in vita. Ma «nel frattempo il mondo era cambiato per davvero […]. Fingere che il tempo non fosse passato significava estinguersi, sprecare la forza della gioventù, vivere vanamente» (p. 28). Un’intera generazione a cavallo dei due mondi – il vecchio, quello romantico e oramai defunto, e il nuovo, quello sconcertante del quale ancora stiamo provando a dare una definizione – non aveva alcuna intenzione di parteggiare né per l’una né per l’altra parte.
I primi anni ’90 sono una parentesi devastante. La coda delle ideologie – il loro ultimo sussulto – si è diffusamente trasformata in tentativi (estremi) di tenerle in vita. Ma «nel frattempo il mondo era cambiato per davvero […]. Fingere che il tempo non fosse passato significava estinguersi, sprecare la forza della gioventù, vivere vanamente» (p. 28). Un’intera generazione a cavallo dei due mondi – il vecchio, quello romantico e oramai defunto, e il nuovo, quello sconcertante del quale ancora stiamo provando a dare una definizione – non aveva alcuna intenzione di parteggiare né per l’una né per l’altra parte.
Il movimento grunge ha riempito il vuoto di chi si trovava spiazzato: ha rappresentato al contempo un grande momento di decadenza e consapevolezza. Il grunge è stato una spugna porosa del presente e delle enormi difficoltà legate all’insicurezza diffusa: l’unica cosa che riusciva a dare un senso alla fase terminale di un’epoca, senza per questo regalare un’alternativa, una piccola luce in cui credere e sperare. Il grunge è stato (e forse ancora è) qualcosa atto a restituire emozioni senza promettere nulla: né un avvenire né la certezza di un disastro.
«Non eravamo spronati dalla ricerca della gloria, non ci importava niente del futuro, non pretendevamo di utilizzare al meglio i nostri giorni. Ciò che cercavamo era solamente un’anestesia che ci destituisse dal presente» (p. 30).
Le ideologie avevano insegnato il contrario: il presente va cambiato, ci sarà necessariamente un avvenire migliore. Ma la generazione nella quale Pomella si trova incastrato non ha più voglia di credere a un futuro migliore che non si è mai realizzato. Il continuo stato di alterazione in cui tenta di sopravvivere, la dissennata perdita di tempo e l’incapacità di stabilire obiettivi a medio-termine, erano cifre portanti di uno stile di vita che il grunge sapeva ascoltare e cullare.
Erano, o sono?
Non viviamo anche oggi condizioni simili? Generazioni che si danno per sconfitte senza essere entrati nella contesa?
Cos’è che ora ha preso il posto del grunge?
La Roma descritta da Pomella non è mai refrattaria, nemmeno quando il caldo ti toglie il respiro e l’umidità sembra sollevarti da terra. E questo non perché Roma sia, in ogni caso, accogliente. Tutt’altro: perché la vita di chi fluttuava costantemente nelle esperienze “grunge” era sulla soglia tra il buio e la luce. Né troppa luce né il buio pesto.
Forse è proprio così che si potrebbe provare a definire il grunge e tutto quello che si trascinava dietro, a volte come una religione altre volte solo come uno “stile di vita”: né l’alternativa A, né l’alternativa Non-A. E così potrei provare a definire lo spaesamento diffuso che si coglie negli occhi di molti giovani coetanei che mi circondano: nessuna alternativa, solo una possibilità di annientamento e azzeramento. Nessuno stimolo proattivo, solo un grande vuoto che niente sembra riuscire a colmare.
Al contrario, i Pearl Jam di Ten, Vs. e Vitalogy sostengono la vita del narratore, il cibo col quale rimanere vivo, l’unica via che riusciva a non farlo precipitare in quell’aporia apparentemente insolubile che è la vita (né A, né Non-A). «Nel caso dei Pearl Jam, tutto ciò di cui avevo bisogno era già lì, nelle canzoni. La mia sete veniva placata semplicemente ascoltando un disco. Non mi serviva altro. Immagino che questa sia, tra le varie forme di godimento artistico, la più perfetta» (p. 69).
Tuttavia, il fulcro narrativo del libro è un’amicizia, quella fra chi scrive e Q, il nuovo chitarrista della band della quale Pomella era il frontman. L’amicizia con Q (una «solida, sbilenca, acida amicizia» p. 23) nacque proprio grazie ai Pearl Jam. «Devi sentire questa» disse, mettendo nell’autoradio una musicassetta dalla copertina rosa.
Il disco era Ten, la prima traccia si intitolava Once.
Tutto ebbe inizio quel giorno sotto la Tangenziale Est con il primo ascolto di Once. Iniziò idealmente proprio quel giorno l’assurdo viaggio che i due compirono nell’agosto 1995. Un viaggio senza meta, qualcosa che serviva solamente a spostare le proprie anime disilluse in giro per l’Europa. Un unico mezzo di sostentamento formato da due chitarre, un’armonica a bocca e una voce. I due cantano per strada, dormono nelle stazioni o dentro case di persone conosciute poco prima, si sbronzano con whisky da quattro soldi (portato da Roma, acquistato per pochi spiccioli alla Standa) e provano a scomparire grazie agli acidi.
C’è qualcosa che però fa attrito; una crepa oscura attraverso la quale comincerà a passare un piccolo bagliore solamente dopo un incidente stradale, una volta tornati a Roma, una sera di settembre sul Grande Raccordo Anulare bagnato da un temporale. L’avanzare della lettura ti permette di capire che retrospettivamente la crepa si poteva intravvedere già tempo prima: Pomella è destinato ad abbandonare un mondo che non ha futuro ma solo un presente dove si accumula un passato fatto di dolore e nostalgia. «Io avevo addosso la speranza» (p. 97): quel terribile sentimento di cui siamo in parte composti – contraltare della paura, come ci insegnano i filosofi stoici. La consapevolezza e la speranza albergavano in quel corpo che provava attraverso l’alcool e la musica dei Pearl Jam a disintossicarsi. La consapevolezza era: la giovinezza finirà; tentare di allungarla immaginando che non sarebbe mai terminata sarebbe stato idiota («avevo la precisa cognizione di ciò che stavo vivendo, ossia della caducità della giovinezza, del terribile inganno che essa cela e che consiste nel tramutare ogni cosa in un ricordo struggente» p. 85).
“Anni luce” è uno svolgersi, a volte quasi didascalico perché straripante, di un flusso di vita apparentemente impossibile da placare se non con un colpo di pistola, come fece con il suo Kurt Cobain – icona indiscussa del movimento grunge. E invece, forse, è l’espressione più dignitosa e sana di una storia inevitabile, di una frattura già consumata fin dal principio. «Credo che in questo mondo – scrive quasi alla fine Pomella – la sorte e la casualità giochino un ruolo molto più grande di quanto siamo propensi a credere» (p. 144) e tuttavia è vero che molto sembra essere già prefigurato, prescritto o almeno tracciato nelle sue linee essenziali.
Il viaggio di Christopher, in Into the Wild, termina nel peggiore dei modi. Eddie Vedder, in uno dei brani più significativi di quella colonna sonora, Guaranteed, canta: «Leave it to me as I find a way to be». Lasciate che sia io a cercare un modo di essere.
“Anni luce” è un libro sulla libertà e sul suo volto più oscuro: l’incapacità di dire a se stessi e agli altri “Lasciate che sia io a cercare un modo di essere”.




